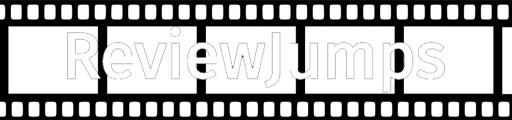Solaris
Nel silenzio eterno dello spazio, là dove il tempo si sfilaccia e la memoria pulsa più viva della realtà, si muove Solaris di Andrej Tarkovskij, non tanto un film quanto un’esperienza sensoriale ed intellettuale scolpita nel metallo freddo della solitudine umana. Già dai primi fotogrammi, Tarkovskij non entra nella fantascienza: vi si insinua. Non ci sono astronavi scintillanti o esplosioni stellari. C’è invece l’acqua che scorre tra le foglie, l’erba che si muove lenta sotto un cielo senza minaccia. La Terra non è il punto di partenza di un’avventura, ma un luogo che si perde, che si dimentica lentamente nel cuore del cosmonauta Kris Kelvin. La fotografia di Vadim Yusov, pittorica e meditativa, è una liturgia dell’immagine: ogni inquadratura è un’icona che invita non a guardare, ma a contemplare. Tarkovskij dirige come un poeta che cesella versi con la macchina da presa. I lunghi piani sequenza non sono vezzi autoriali, ma necessità espressive: ci obbligano a sostare, a respirare con i personaggi, ad entrare nei loro silenzi. Il ritmo è rallentato, spesso accusato di essere ostico. Ma in realtà è un’evocazione, una trance cinematografica dove il tempo è manipolato per diventare sostanza, come l’oceano pensante che avvolge il pianeta Solaris. La scenografia dell’astronave non è sterile high-tech, ma un organismo vivente, stranamente umano: corridoi labirintici, stanze piene di libri, specchi, quadri… residui di una civiltà che cerca di portare l’anima nello spazio, e lì si perde. Il suono, curato con sapienza, alterna il minimalismo assoluto ad incursioni nel sacro grazie alla colonna sonora di Eduard Artemyev: Bach, filtrato da sintetizzatori, non è mai decorativo, ma un richiamo alla trascendenza. La macchina narrativa si costruisce attorno all’indagine interiore di Kelvin, che sulla stazione orbitante incontra Hari, sua moglie morta, tornata in una forma “creata” dall’oceano. Il concetto di “visitatori” generati dai ricordi è una delle più sottili metafore del cinema stesso: Solaris diventa specchio vivente dell’anima, e Tarkovskij lo usa per indagare ciò che ci rende umani, non ciò che ci proietta tra le stelle. Gli effetti speciali sono ridotti al minimo: è la potenza dell’idea, non il virtuosismo, a generare lo stupore. Anche il montaggio rifiuta le regole classiche: si dilata, si contorce, torna su sé stesso come i ricordi che tormentano i protagonisti. Non c’è catarsi, non c’è eroe, ma solo la presa di coscienza che l’uomo non è fatto per comprendere tutto, e che il dolore, come l’amore, è il vero mistero dell’universo. Solaris è, in definitiva, una stazione spaziale della mente. Un’opera che non si guarda, si attraversa. Non si capisce, si sente. Tarkovskij, più che raccontare, plasma un’esperienza filmica che somiglia ad un sogno lucido: instabile, circolare, infinitamente umano. In essa, la tecnica cinematografica diventa linguaggio spirituale, e ogni scelta formale – regia, fotografia, suono, montaggio – è un passo in una meditazione sul significato stesso dell’esistenza.
Trama – fonte: www.comingsoon.it
Lo scienziato Kris Kelvin vive in una dacia vicino ad un lago immerso nel verde. Accanto a lui ci sono il padre e una signora di nome Anna. Kris sta trascorrendo le sue ultime ore sulla Terra: è stato incaricato di raggiungere la base spaziale orbitante attorno al pianeta Solaris e decidere le sorti di quella spedizione. Le indagini scientifiche, infatti, sembrano essersi ormai arenate. Lo capiamo dal filmato che Berton, un vecchio astronauta, mostra a Kris e ai suoi familiari. Al contrario di Berton, Kris si dimostra scettico nei confronti del futuro delle ricerche. La sera, Kris brucia delle vecchie carte; tra di esse, la foto di Harey, la moglie morta dieci anni prima. Giunto sull’astronave, Kris incontra il cibernetico Snaut e il freddo scienziato Sartorius. Il terzo componente della spedizione, Gibarjan, si è suicidato, lasciando però una confessione videoregistrata proprio per Kris. Sulla stazione paiono esserci altre presenze: “ricordi”, suggerisce Snaut, materializzazioni dell’inconscio apparentemente inoffensive ma che in realtà tormentano gli astronauti nel profondo dell’animo. Kris se ne rende ben presto conto di persona: accanto a lui vede comparire Harey. Costei, come gli altri “ospiti”, è fatta di neutrini e può vivere solo nell’orbita di Solaris. Eppure, a poco a poco, acquista una sensibilità umana, attaccandosi sempre più a Kris. Quest’ultimo rimane “invischiato” a tal punto da subordinare la sua missione a quella disperata storia d’amore. E’ la stessa Harey a prendere in mano la situazione e a volere la messa in opera di una delle strategie ideate da Sartorius per liberarsi degli ospiti, l'”annichilazione”. La pace sembra ritornata a bordo della stazione orbitante: per Kris è tempo di tornare sulla Terra. Eccolo camminare di nuovo nei pressi del lago e raggiungere la propria casa. Il padre esce e il figlio si inginocchia davanti a lui, abbracciandolo. La cinepresa s’innalza vertiginosamente, a mostrarci dall’alto la casa che pare sorgere su di un’isoletta circondata dall’oceano di Solaris.
Cast – fonte: www.comingsoon.it
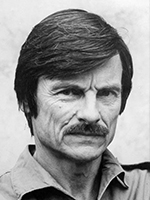
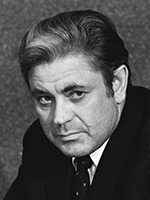




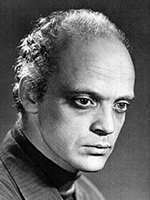
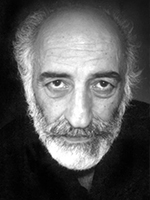

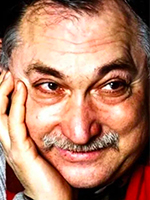


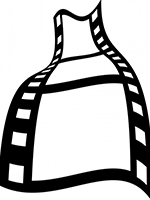


Trailer
Riconoscimenti – fonte: www.mymovies.it
Il film ottenne il premio speciale della giuria al Festival di Cannes del 1972.
Curiosità – fonte: www.gw2ru.com – it.wikipedia.org – fearplanet.net
1. Una risposta a Kubrick?
Molti hanno interpretato Solaris come una risposta sovietica a 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Tarkovskij, tuttavia, criticò il film di Kubrick per la sua freddezza emotiva e l’eccessiva enfasi sulla tecnologia, preferendo esplorare la dimensione interiore dell’uomo.
2. Dissapori con l’autore del romanzo.
Stanisław Lem, autore del romanzo originale, non fu soddisfatto dell’adattamento cinematografico. Criticò Tarkovskij per aver trasformato la sua opera in un dramma psicologico, allontanandosi dalle tematiche scientifiche e filosofiche centrali del libro.
3. Colonna sonora innovativa.
La musica del film combina composizioni elettroniche di Eduard Artemyev con brani di Johann Sebastian Bach, in particolare il preludio corale “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” (BWV 639). Questa fusione crea un’atmosfera unica che riflette la dualità tra tecnologia e spiritualità.
4. Presenza di opere d’arte.
All’interno della stazione spaziale, Tarkovskij inserisce riproduzioni di opere di Pieter Bruegel il Vecchio, come “Cacciatori nella neve” e “La caduta di Icaro“. Questi elementi artistici sottolineano la connessione tra l’uomo e la sua cultura, anche nello spazio profondo.
5. Scena girata a Tokyo.
La lunga sequenza automobilistica è stata girata a Tokyo, in Giappone. Tarkovskij utilizzò questa scena per ottenere i permessi necessari per girare all’estero, sfruttando l’ambientazione futuristica delle autostrade giapponesi.
6. Creazione dell’oceano di Solaris.
L’oceano pensante del pianeta Solaris è stato realizzato utilizzando una miscela di acétone, polvere d’alluminio e coloranti. Questa tecnica artigianale conferisce al film un aspetto visivo distintivo.
7. Riconoscimenti internazionali.
Solaris è stato uno dei film di Tarkovskij più riconosciuti a livello internazionale. Ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes nel 1972, contribuendo a consolidare la reputazione del regista nel panorama cinematografico mondiale.